
Proprio oggi, tre anni fa, ci lasciava David Sassoli. Davamo l’ultimo saluto, ricorro all’espressione usata dalla senatrice Liliana Segre, a “un patriota europeo”. Parole bellissime. Perché vere. E perché ponevano giustamente Sassoli accanto a quelli che – cito uno per tutti – come Jacques Delors, si erano spesi per dare un cuore palpitante e membra robuste al sogno dei Padri fondatori.
Sappiamo bene che oggi l’Europa vive un tempo segnato da eccezionali sfide. Attraversata da rigurgiti nazionalisti sempre più aggressivi e incapace di conquistarsi uno spazio autorevole in un mondo dove ricompaiono tentazioni “imperiali” e scalano le vette del potere politico nuove oligarchie miliardarie allergiche alle regole del sistema liberaldemocratico, nuovi “padroni del vapore” che devono forza e ricchezze al controllo delle piattaforme e degli algoritmi.
Al giro di boa del primo quarto del secolo l’Europa arriva incerta, smarrita. Ferma sulle gambe mentre il mondo attorno corre. E la direzione è tutt’altro che rassicurante.
Il classico “che fare” è ben chiaro. Concordare una politica estera e di difesa. Mettere mano al modo di decidere ponendo fine al ricatto dei veti. E, sul piano economico, allargare lo spazio al ricorso al debito comune – così come stabilito con il Next Generation Eu dopo la pandemia – per dare ossigeno al sistema produttivo e alle politiche sociali delle aree in maggiore difficoltà.
Ma tutto resta confinato nei dibattiti e nei report. E, come ci ricorda il Presidente della Repubblica, l’alternativa all’azione è l’arretramento.
L’Europa segna il passo perché una volta dispersa nelle nebbie del tempo quella ragione che ispirò i padri fondatori – pace tra noi perché mai più la mala bestia della guerra torni a straziare i nostri popoli – la cultura e la politica non sono riuscite a plasmare un’idea, un sentimento che avesse forza uguale e contraria a “nazione” tale da attirare, affascinare, convincere, entusiasmare e anche innamorare. Tanto più indispensabile e vitale oggi quando a dominare non è più la fiducia nel futuro, la forza di ri-costruire, l’energia che spinge a nuovi approdi, il desiderio di guardare fuori e anche lontano dal proprio cortile, ma al contrario la paura del domani, il timore di perdere quel tanto o poco che si possiede, il sospetto degli “estranei” e quindi la convinzione che nella propria piccola comunità locale o nazionale ci sia più possibilità di attrezzare la difesa, rendere più sicura la trincea.
E non sarebbe nemmeno complicato se solo si riscoprisse la ricchezza e la fecondità della sua cultura umanistica. La persona, il valore delle relazioni, il senso della comunità, la dimensione trascendente, l’attenzione agli ultimi, lo sguardo verso l’altro: da questo composto può essere plasmata quell’idea capace di muovere sentimento, fiducia, passione, volontà. Vengono alla mente gli interrogativi amari elencati da Papa Francesco quasi dieci anni fa: “Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di filosofi, di poeti, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?”.
E sono proprio queste domande a indicarci la strada da percorrere prima che sia troppo tardi. Serve un’anima all’Europa. E la via è proprio quella che ci ha indicato David Sassoli: coniugare grande saggezza e massimo d’audacia.
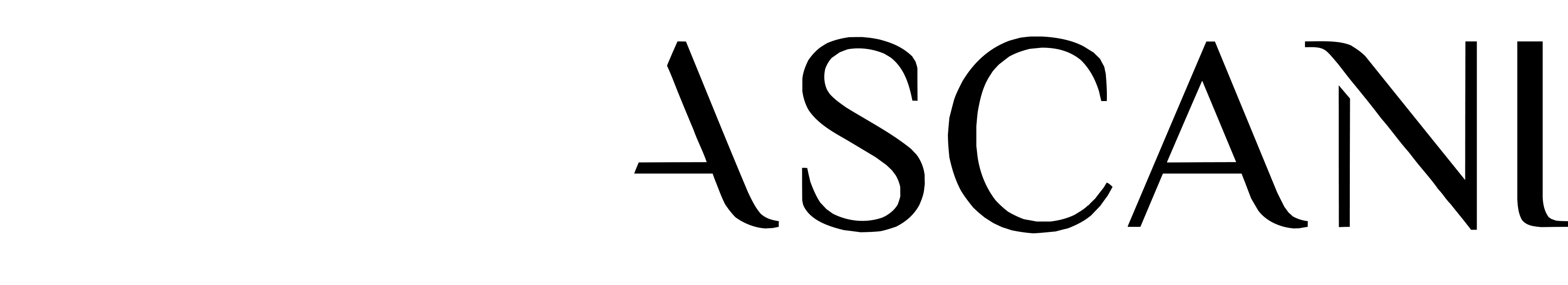
Caro Davide, manchi all’Europa e a tutti noi…. Mancano le tue convinzioni ,la fermezza di un Europa più sociale a partire dagli ultimi .. Necessità lattuazione del tuo progetto di solidarietà e uguaglianza .. Ovunque tu sia noi saremo sempre con te con il ❤️🌹Proteggici tutti…..🙏In
Un uomo eccezionale, purtroppo ci manca ma soprattutto manca all’Europa, i giovani dovrebbero prenderlo come esempio di vita noi vecchi compagni lo porteremo per sempre nel nostro cuore. Tantissimi Auguri a Lei ed ai suoi cari.
Giuseppe Gaudenzi – Assisi